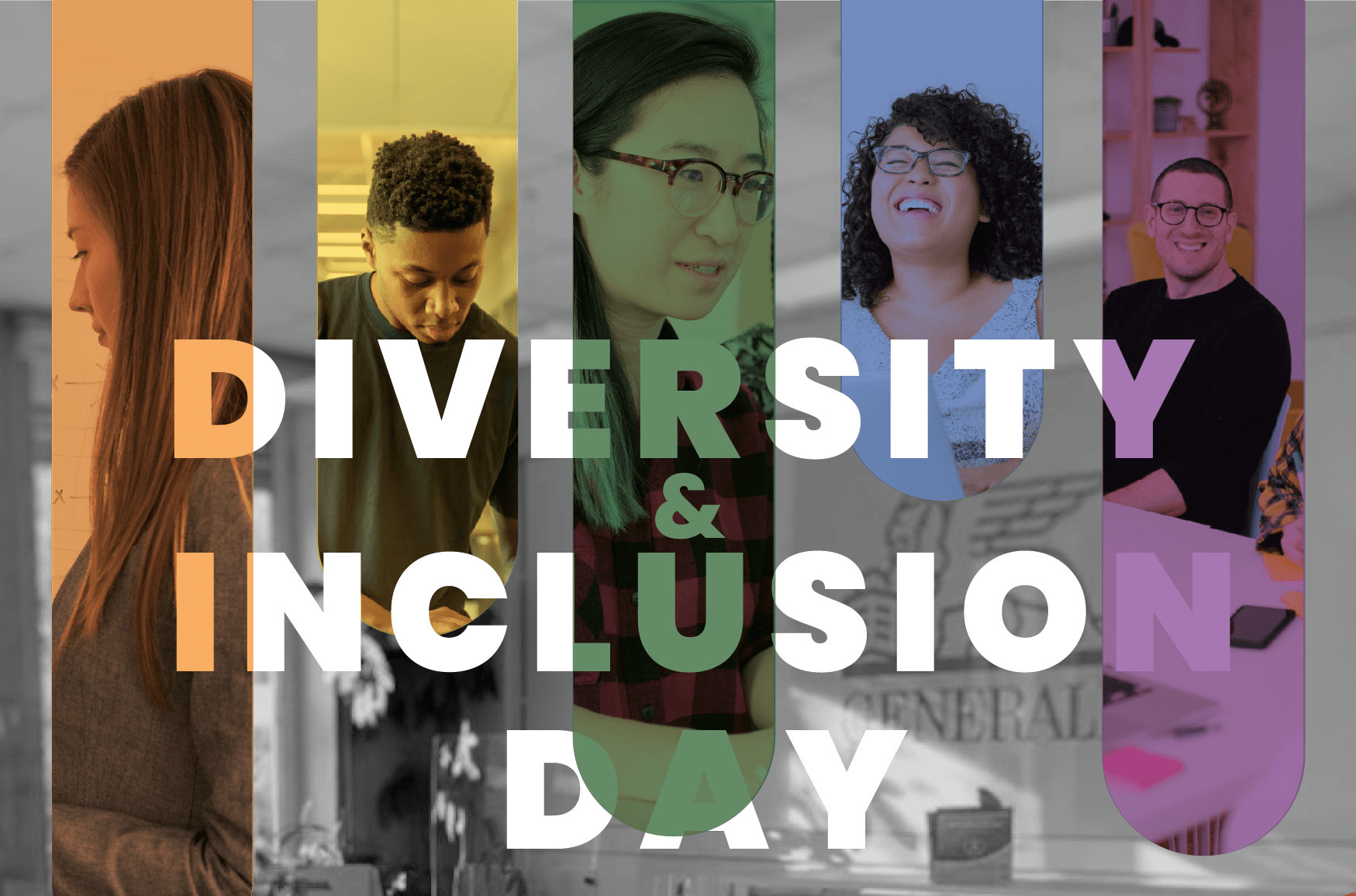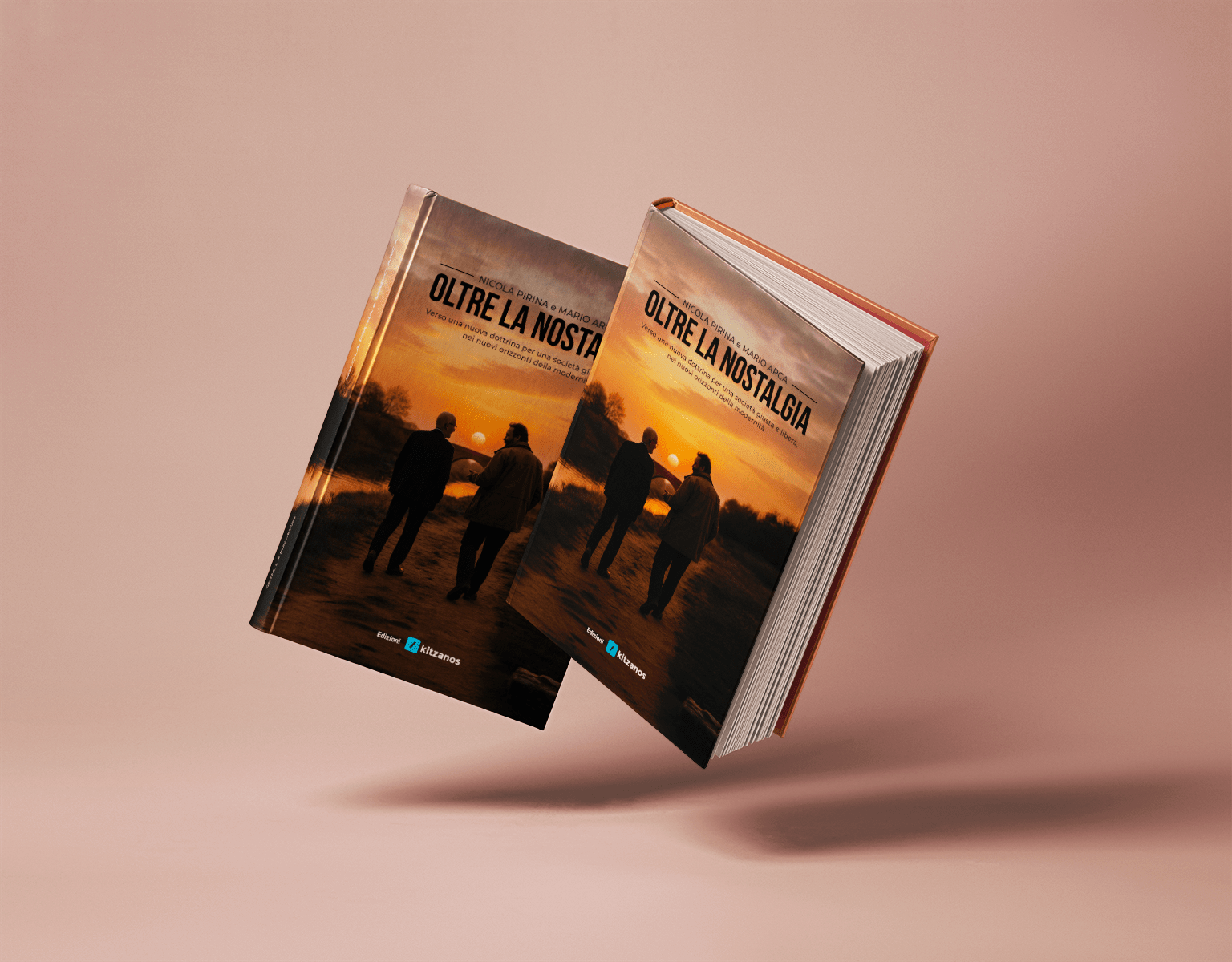C’è un rumore che non sentiamo, ma che non smette mai, è il battito dei data center, le nuove cattedrali del mondo.
Non hanno campanili né finestre.
Non profumano d’incenso, ma di ozono e silicio.
Sono i templi dove la civiltà contemporanea prega i suoi nuovi dèi: i dati.
In quelle architetture senza volto, nascono e muoiono miliardi di informazioni ogni secondo.
Là dentro si custodisce la memoria collettiva del pianeta, si formano i modelli dell’intelligenza artificiale, si decide la velocità della conoscenza.
Eppure, la maggior parte dei cittadini e dei decisori non saprebbe dire dove si trovano, chi li controlla, quanto consumano, perché sono così cruciali per il futuro dell’Europa.
Siamo entrati nell’era della fisica dell’informazione, ma la nostra consapevolezza è rimasta nella metafisica dei tweet.
Chi pensa ai data center come a grandi server ha perso la misura.
Un data center oggi è come un porto, una centrale elettrica, un aeroporto del pensiero.
Lì dentro transitano energia, algoritmi, privacy, sicurezza nazionale e potere geopolitico.
Sono i nuovi snodi dell’economia cognitiva.
L’Europa ne conta oggi circa 6.000, concentrati soprattutto in Irlanda, Paesi Bassi, Germania e nei paesi nordici.
L’Italia, invece, è ancora sotto dimensionata: meno di 200 strutture di scala significativa, di cui pochissime hyperscale (cioè sopra i 10 MW di capacità energetica).
Siamo la periferia fisica di un’infrastruttura di cui però usufruiamo quotidianamente.
Questo significa che ogni volta che interagiamo con un servizio AI, la nostra intelligenza digitale viaggia verso altri paesi.
Il futuro, letteralmente, non risiede in Italia: lo affittiamo a ore.
Ogni rivoluzione industriale ha avuto la sua energia.
La prima: il carbone.
La seconda: l’elettricità.
La terza: il petrolio.
La quarta, quella digitale, ha un combustibile invisibile: il dato.
E per elaborarlo servono macchine, energia e architettura.
L’intelligenza artificiale non esiste nel vuoto.
Vive in luoghi concreti: hangar di acciaio, silenziosi, freddi, affamati di energia e acqua.
Ogni modello linguistico, ogni algoritmo predittivo, ogni rete neurale che usiamo ogni giorno — da Chat GPT ai sistemi di guida autonoma — si addestra e si alimenta in questi bunker tecnologici.
E allora la domanda vera non è “chi ha l’AI migliore”, ma chi controlla le infrastrutture che la rendono possibile.
Perché lì si gioca la sovranità del futuro.
L’Unione Europea è bravissima a scrivere norme — meno a costruire potenza.
È l’unico continente che ha affrontato la questione etica dell’intelligenza artificiale prima ancora di quella economica, con l’AI Act.
Un gesto civile, ma anche rischioso, se non accompagnato da una politica industriale all’altezza.
Oggi l’Europa rappresenta meno del 15% della capacità globale di calcolo.
Il resto è diviso tra Stati Uniti (40%), Cina (35%) e il resto del mondo (10%).
Questo significa che mentre discutiamo di regole, altri addestrano i modelli, accumulano dati, consolidano vantaggi.
Il rischio è che l’Europa diventi il continente che discute i diritti del futuro senza partecipare alla sua costruzione materiale.
Una potenza etica, ma tecnologicamente subalterna.
L’Italia si trova davanti a una scelta storica: diventare hub mediterraneo del calcolo europeo o restare l’ultimo miglio dei cloud americani.
Negli ultimi anni qualcosa si muove:
Microsoft ha aperto una regione cloud in Lombardia.
Google ha avviato investimenti tra Milano e Torino.
Amazon Web Services espande in Piemonte e Lazio.
Leonardo, Cineca, ENI e il supercomputer Leonardo di Bologna (tra i più potenti d’Europa) rappresentano eccellenze reali.
Ma tutto questo resta frammentato, poco coordinato, con un’infrastruttura di rete ancora incompleta, e una politica energetica non allineata.
Il rischio è costruire isole di eccellenza in un mare di inefficienza strutturale.
Se l’Italia vuole giocare nel campionato del calcolo, deve pensare come un sistema, non come un insieme di progetti.
Un singolo data center di grandi dimensioni consuma quanto una città di 100.000 abitanti.
Ogni query AI richiede energia elettrica, raffreddamento e infrastruttura.
L’intelligenza artificiale è un divoratore di risorse fisiche.
E allora la domanda è: possiamo permetterci l’intelligenza che stiamo costruendo?
Nei paesi nordici, i data center si alimentano con fonti rinnovabili e sfruttano il clima freddo per il raffreddamento naturale.
In Italia e nel sud Europa, dove il clima è più caldo e la rete energetica più fragile, il problema è più complesso.
Ecco perché l’Europa sta iniziando a parlare di data center sostenibili, integrati in ecosistemi energetici locali, capaci di riutilizzare il calore residuo per riscaldare quartieri o serre.
Non più solo macchine che pensano, ma macchine che restituiscono.
Nell’epoca della AI, la sovranità non è militare né economica, è informazionale.
Chi controlla i dati controlla il futuro.
E oggi la maggior parte dei dati europei risiede fisicamente in infrastrutture di proprietà americana o asiatica.
Questo significa che le nostre scuole, ospedali, imprese, pubbliche amministrazioni, persino i nostri algoritmi pubblici, girano su server che non ci appartengono.
Il progetto GAIA-X, lanciato da Francia e Germania nel 2020, nasceva proprio per creare un’infrastruttura cloud europea sovrana.
Ma il progetto si è impantanato tra burocrazie, lobby e lentezze nazionali.
Un’altra occasione sprecata per mancanza di visione condivisa.
Serve una dottrina europea del dato, non solo regole.
Un patto di alleanza infrastrutturale tra stati membri, capace di unire potenza di calcolo, energia e ricerca in un unico sistema continentale.
Dietro la corsa all’AI si nasconde un’altra questione: dove mettiamo la nostra intelligenza collettiva?
Non solo in senso tecnico, ma culturale.
Un data center non è un’entità neutra: modifica il paesaggio, consuma energia, richiede connessioni, genera calore.
Ogni volta che lo costruiamo, stiamo ridefinendo la geografia del sapere.
L’Italia, con la sua posizione geografica e il suo patrimonio energetico rinnovabile in espansione (fotovoltaico, eolico, idrogeno verde), potrebbe diventare il nuovo corridoio mediterraneo dell’informazione.
Un ponte tra Africa, Europa e Medio Oriente.
Ma serve una visione che unisca industria, ambiente e cultura.
Un data center costruito in Sardegna, in Puglia o in Sicilia non deve essere solo un’infrastruttura tecnica: deve diventare un presidio di intelligenza territoriale, un laboratorio di energia e conoscenza distribuita.
L’Europa non vincerà mai la gara dell’AI sul piano della potenza computazionale pura.
Gli Stati Uniti hanno il capitale.
La Cina ha i dati e la scala.
Noi abbiamo la coscienza.
L’unico modo per rendere competitiva l’intelligenza artificiale europea è costruire una AI etica, trasparente, democratica e culturalmente contestuale.
Un’intelligenza che non si limiti a calcolare, ma che interpreti.
Che riconosca la diversità linguistica, i valori sociali, le radici culturali.
Perché la vera sfida non è costruire AI più potenti, ma costruire AI più umane.
E questo è un compito profondamente europeo.
Serve una scuola di pensiero e di industria che unisca scienziati, filosofi, sociologi, linguisti, giuristi e artisti.
Non solo per costruire modelli, ma per costruire significato.
Il sud dell’Europa può essere la nuova frontiera della potenza di calcolo, a condizione di integrarla con energie rinnovabili, politiche industriali e cultura.
La Sardegna, per esempio, potrebbe ospitare data center alimentati da energia solare e eolica, raffreddati con sistemi a circuito d’acqua marina, e integrati con progetti di AI per la gestione territoriale e ambientale.
Un modello di AI ecologica, che unisca potenza e consapevolezza.
Un laboratorio dove la tecnologia non è solo industria, ma politica e cultura.
Il Mediterraneo, da culla della civiltà, può diventare culla della nuova intelligenza — se smettiamo di pensarci come periferia e iniziamo a ragionare come piattaforma.
L’intelligenza artificiale non è una nube eterea.
È un sistema fisico, con radici, cavi, consumo e impatto.
E se non scegliamo dove metterla, qualcun altro lo farà per noi.
L’Europa deve smettere di essere il continente delle buone intenzioni e tornare a costruire infrastrutture di civiltà.
Non basta regolare l’intelligenza, bisogna abitarla.
E l’Italia deve decidere se vuole essere utente o architetto, consumatore o costruttore, cloud periferico o cervello strategico.
Perché il futuro non sarà scritto dai paesi più grandi, ma da quelli più intelligenti nel costruire la propria intelligenza.
L’AI è la nuova lingua del mondo.
Ma senza data center sovrani, energia pulita, e cultura critica, resteremo una civiltà che pensa in outsourcing.
Chi non ha infrastruttura, non ha futuro.
Chi non ha etica, non ha direzione.
Chi non ha visione, non ha voce.
L’Europa deve tornare a essere tutte e tre le cose insieme.