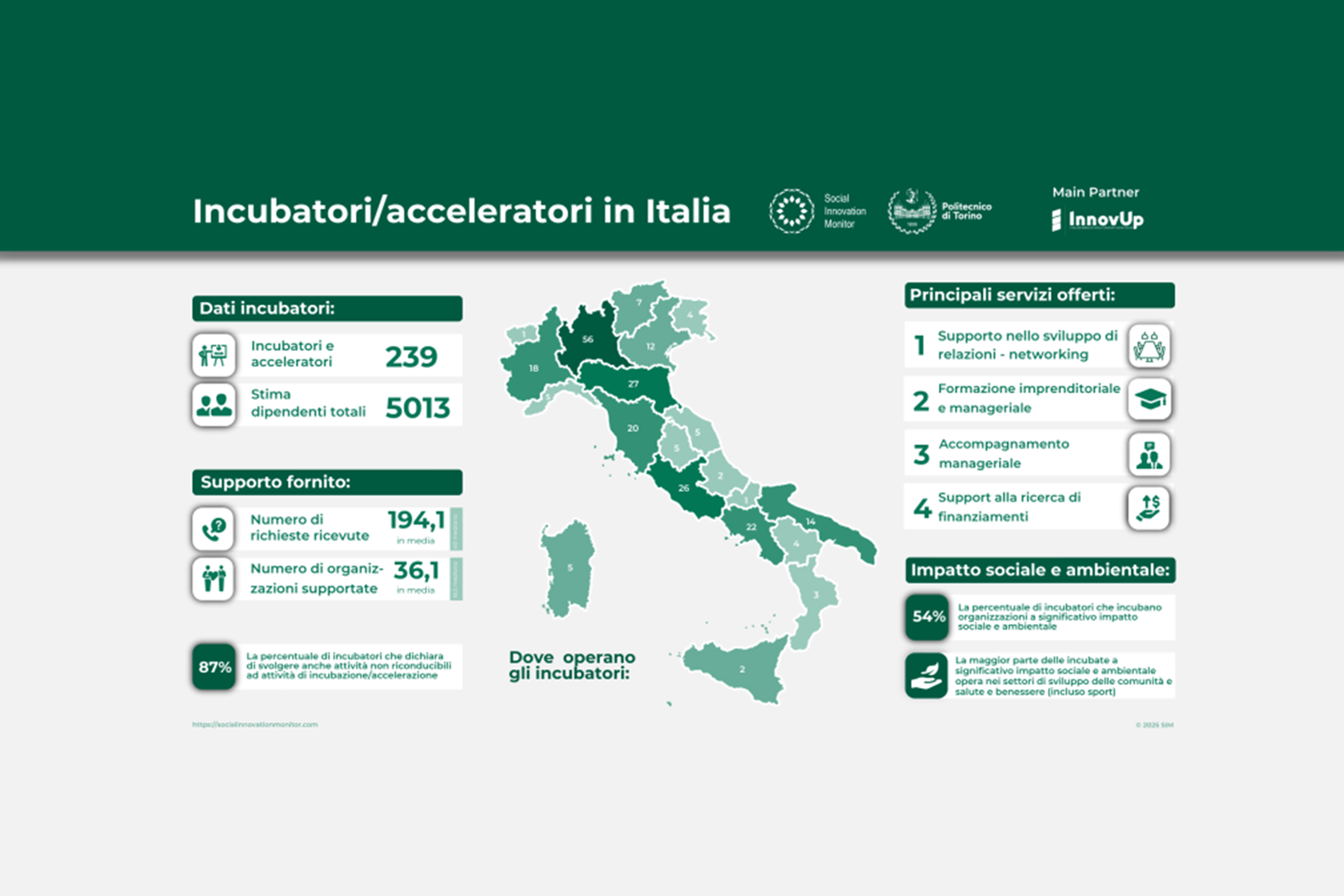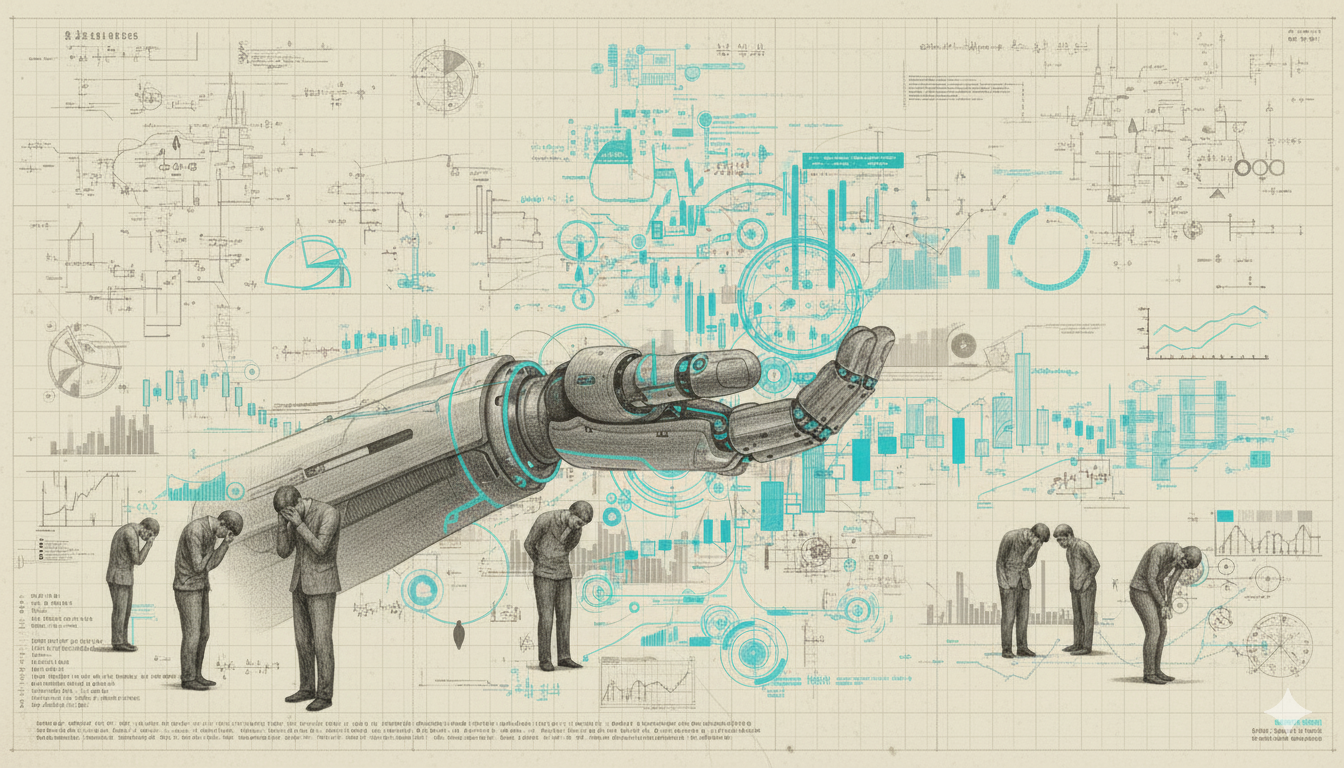C’è sempre stato, nell’uomo, un desiderio di velocità.
Dalla prima ruota che accorciava i tempi della fatica alla locomotiva che sfrecciava tra i campi, dal futurismo che idolatrava il motore al mito della connessione in tempo reale.
La velocità era promessa di libertà, emancipazione, possibilità di fare di più.
Poi è arrivato il capitalismo globalizzato e da promessa la velocità è diventata condanna.
Il fine non è più liberare, ma saturare.
Non più aprire spazi, ma ingozzare.
Così siamo entrati nell’era dei fast food.
Il gusto ridotto a carburante, la cucina trasformata in catena di montaggio, il rito dello stare a tavola spazzato via dal packaging di cartone.
Poi è arrivato il fast fashion.
La stoffa come usa e getta, lo stile come algoritmo stagionale, la moda come pattumiera globale.
Poi il fast music.
Canzoni pensate per i quindici secondi di un social, melodie compressate come bibite gassate, artisti trasformati in fornitori di contenuti.
Ma non è finita.
Abbiamo sdoganato il fast thinking.
Opinioni immediate, senza analisi, slogan al posto di idee.
Il fast politics.
Decisioni di pancia, leggi scritte come tweet, governi che vivono la durata di un trend.
Il fast love.
Relazioni mordi e fuggi, connessioni ridotte a swipe, il tempo dell’approfondimento sostituito dalla bulimia dell’esperienza.
È possibile che l’ingordigia richieda solo velocità?
Che il valore sia stato confuso con la rapidità, la quantità con la qualità, il consumo con la vita?
Colpevoli tutt*.
Le corporations hanno imposto il modello, piegando intere catene produttive all’imperativo della rotazione continua.
Ma i consumatori hanno applaudito, attratti dall’illusione di poter avere tutto e subito, senza accorgersi che stavano perdendo il meglio: il tempo, l’attesa, la maestria.
Le società hanno fatto il resto.
Hanno educato all’istantaneità, sostituito il silenzio con la notifica, la contemplazione con lo scroll infinito.
Il fast non è più un settore, è un ecosistema.
Una (sub)cultura che ci vuole efficienti come macchine, compulsivi come tossici, mai sazi come algoritmi.
Abbiamo perso la riflessività e lo scrupolo come forma e strumento di pensiero.
Chi ci prova oggi viene bollato come nostalgico, quando invece è visionario.
Solo chi rallenta può osservare, distinguere, scegliere.
Abbiamo perso la dignità del lavoro.
L’artigiano che cuciva un abito per durare decenni è stato sostituito da mani invisibili e sottopagate che cuciono per due euro l’ora abiti che dureranno due lavaggi.
Abbiamo perso il rapporto con la terra: monoculture, allevamenti intensivi, cibi senza stagioni né sapore.
E intanto il pianeta affoga nei rifiuti del nostro fast.
Magliette indossate due volte e già dismesse.
Plastica che galleggia come continenti.
Relazioni bruciate alla stessa velocità di un feed che si aggiorna.
Non tutto è perso.
C’è un’uscita, ma richiede coraggio.
Smettere di correre.
Non nel senso di immobilizzarsi, ma di scegliere il ritmo giusto.
Ricominciare a dare valore al tempo, a chi lo usa per creare con maestria, a chi coltiva senza forzare i cicli della natura, a chi scrive una canzone non per i trend ma per la memoria.
Serve una cultura del slow che non sia un lusso per pochi, ma un diritto per tutti.
Una politica che non rincorra la notizia del giorno, ma progetti decenni.
Una scuola che non riempia di nozioni in fretta, ma educhi a pensare con profondità.
Una società che smetta di idolatrare la velocità e riscopra l’attesa, l’approfondimento, il valore delle cose fatte bene.
Dobbiamo sentirci tutt* colpevoli, perché tutti siamo complici.
Ma la colpa non è un marchio: è un invito al riscatto.
Se abbiamo barattato qualità con rapidità, possiamo invertire lo scambio.
Non ci sarà mai un algoritmo che cucini come una nonna, che scriva come un poeta vero, che ami come chi ha pazienza di ascoltare.
La storia non è mai stata fatta dai più veloci, ma da chi ha avuto la forza di durare.
E allora la domanda finale non è se la qualità sia tramontata.
La domanda vera è: abbiamo ancora fame di attesa?
O ci accontentiamo del rigurgito istantaneo del mondo fast?
Chi sceglie la lentezza oggi non è un nostalgico.
È un rivoluzionario.