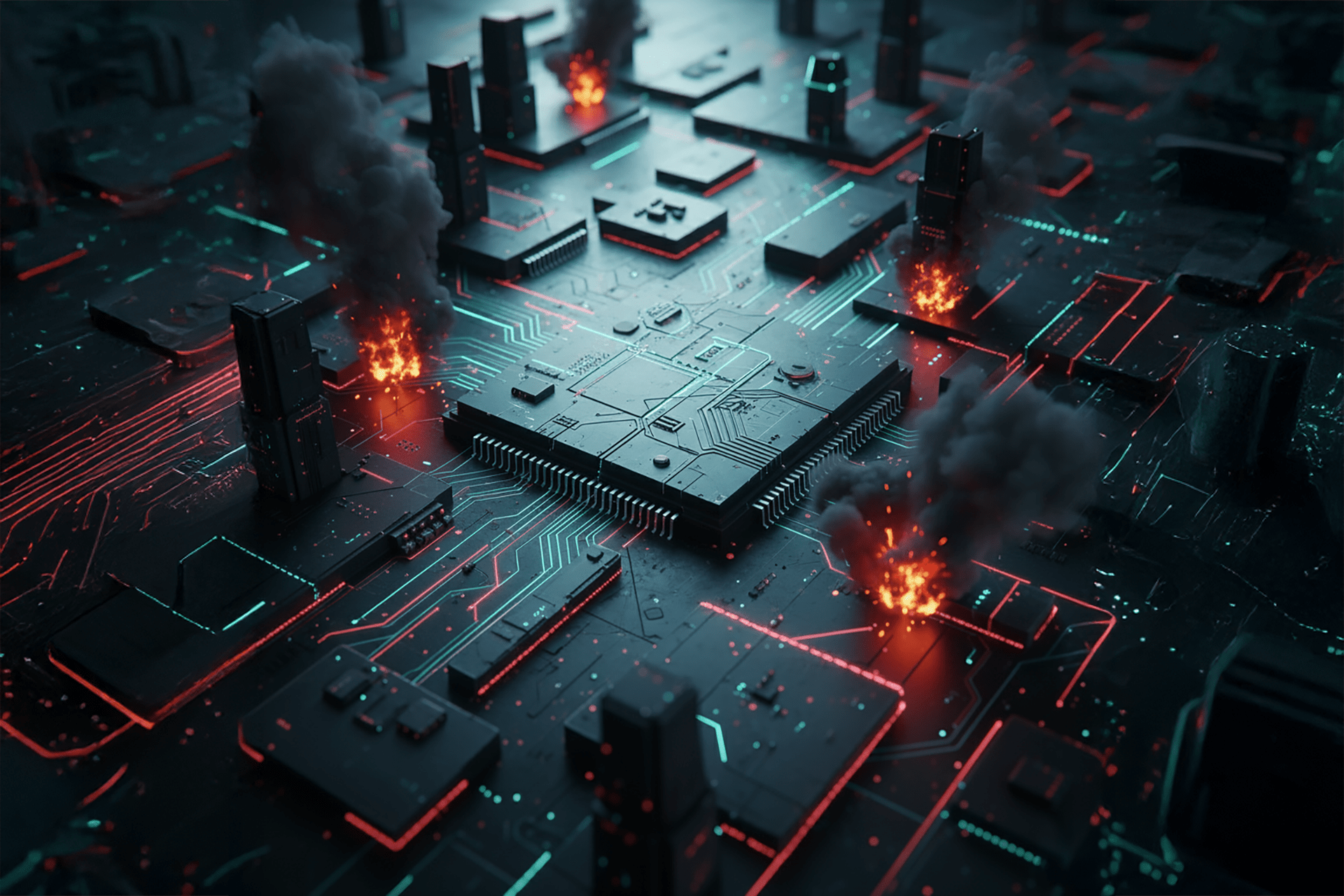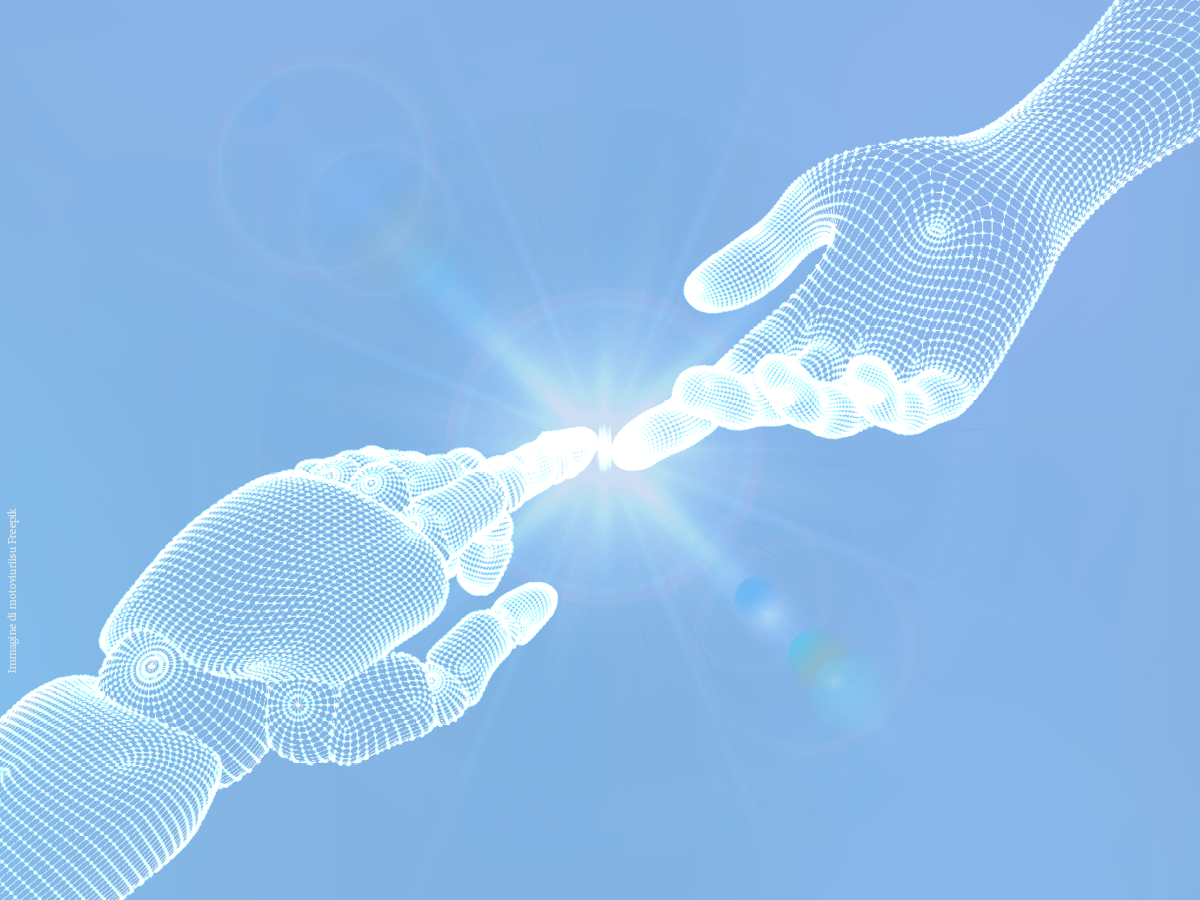Cosa c’entrano Gaza, Taiwan, l’Ucraina e la Sardegna con i chip e la coscienza artificiale?
Una volta si facevano le guerre per il petrolio.
Oggi per l’accesso al know-how, ai chip e agli algoritmi.
L’oro nero ha cambiato forma, è diventato silicio, potenza computazionale, proprietà intellettuale.
E non serve una guerra calda per controllarli, bastano: embargo, accordi di licenza, blocchi all’export, sabotaggi cyber e strette diplomatiche.
Nel 2025, la geopolitica si misura in teraflop.
Chi ha accesso ai semiconduttori avanzati, ai modelli di AI più potenti e alla capacità di generare innovazione strutturale domina.
Il resto del mondo resta clientelare, coloniale, dipendente.
La guerra tecnologica non è uno scenario.
È già iniziata.
I teatri sono paralleli, interconnessi e apparentemente distanti.
Gaza: Israele schiera AI predittiva e tecnologie di riconoscimento automatico per definire bersagli con efficienza asettica.
Ucraina: l’Europa scopre quanto è indietro nell’indipendenza digitale e si appoggia a infrastrutture americane per comunicazioni sicure, analisi satellite e AI difensiva.
Taiwan: il cuore pulsante della produzione globale di chip, da cui passa oltre il 60% dei semiconduttori avanzati del pianeta, è costantemente sotto minaccia cinese.
Iran: sanzionato ma resiliente, continua a sviluppare infrastrutture tech sotterranee, anche grazie a triangolazioni con Cina e Russia.
India: sempre più ago della bilancia, grazie a un gigantesco piano industriale di re-shoring, AI governance, chip-fab locali e neutralità strategica.
Russia: isolata e costretta a un’accelerazione sovranista sul fronte AI e quantum, in sinergia con l’asse Pechino-Teheran.
La sfida USA–Cina è frontale, ma lo scenario è più affollato.
Gli Stati Uniti rispondono con il CHIPS Act (280 miliardi di $ per ricostruire l’indipendenza produttiva), mentre Pechino ha risposto con DeepSeek, una creatura tanto potente quanto inquietante, capace di allenare modelli AI su larga scala anche senza GPU NVIDIA, aggirando gli embargo USA.
Israele e Taiwan, pur piccole, sono iperpotenze tech: la prima nella difesa intelligente, la seconda nella manifattura più avanzata.
L’India sta emergendo.
L’Europa è spettatrice pagante.
Non si tratta di chatbot.
Le AI moderne sono sistemi agenti, capaci di decisioni autonome, ottimizzazione delle risorse, identificazione obiettivi e in alcuni casi scelte letali in ambito militare.
Le implicazioni sono filosofiche prima che tecniche.
Chi programma queste AI?
Con quali valori?
Con quali dataset?
Chi decide cosa è un comportamento ostile?
L’algoritmo può uccidere, può raccomandare, può manipolare le masse e può sbagliare.
Mentre l’AI è già operativa, il quantum computing è una minaccia latente.
Chi riuscirà a costruire una macchina quantistica stabile, operativa e scalabile potrà decifrare qualsiasi crittografia oggi esistente.
Tradotto: accesso totale a dati, segreti di stato, conti bancari, comunicazioni diplomatiche e militari.
Cina e USA sono in corsa.
L’India ha lanciato un programma nazionale da 750 milioni di dollari.
L’Europa ha i cervelli, ma non l’autonomia.
Il vero deterrente del XXI secolo non è nucleare.
È quantico.
Mentre il mondo si ristruttura attorno a filiere nazionali, alleanze tech e blocchi autarchici, l’Unione Europea sembra aggrappata alla retorica regolatoria e a bandi intermittenti.
Abbiamo cervelli, università, storie industriali e cultura critica.
Ma non abbiamo una visione strategica condivisa.
Manca la capacità di dire: “questa è la nostra AI, questo è il nostro chip, questa è la nostra difesa informatica”.
E l’Italia?
Troppo occupata a parlare di incentivi auto, bonus edilizi e tagli lineari.
Manca una regia.
Manca un hub.
Manca coraggio.
In questo scenario globale, ci sono luoghi che possono diventare snodi vitali e neutri per l’innovazione critica.
La Sardegna è uno di questi.
Geograficamente isolata, ma connessa, ideale per infrastrutture strategiche.
Socialmente stabile e culturalmente europea, ma con una propria identità forte.
Energeticamente tende al rinnovabile, ideale per data center, cloud green, calcolo quantico.
Accademicamente vivace, ma ancora sottoutilizzata.
Immaginare la Sardegna come hub di test per AI etica, quantum open-source, fabbriche intelligenti, esperimenti di sovranità digitale europea non è utopia.
È strategia.
La sua neutralità, il suo spazio fisico, la sua libertà simbolica la rendono perfetta per accogliere ciò che il mondo cerca.
Fiducia, visione e resilienza.
Questa nuova guerra non ha trincee visibili.
Ma si combatte ogni giorno, in ogni bando, in ogni brevetto, in ogni export control.
Chi domina i linguaggi dell’intelligenza, dell’elaborazione e della simulazione scrive le regole. Gli altri le subiscono. Oppure resistono. Oppure si reinventano.