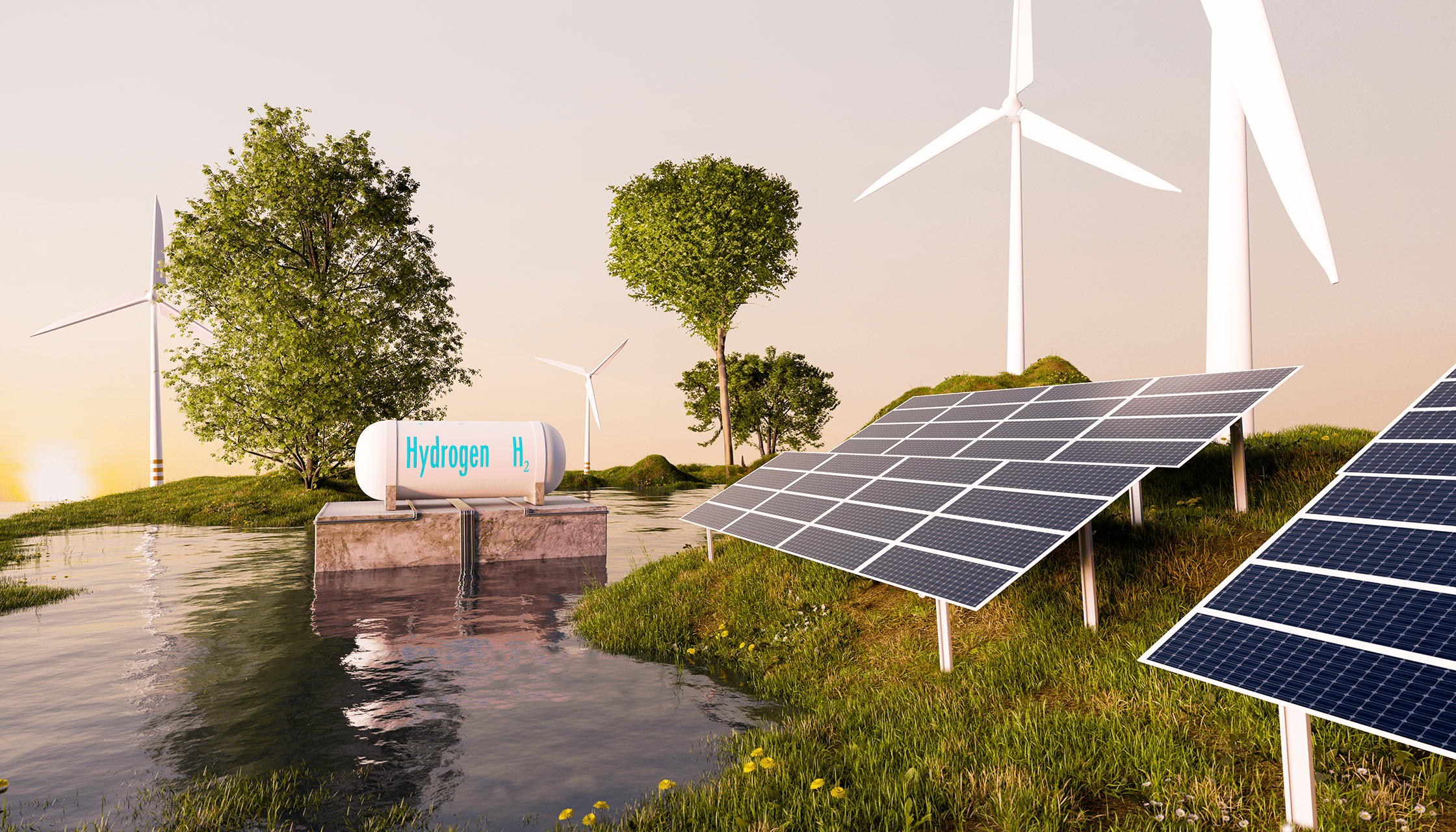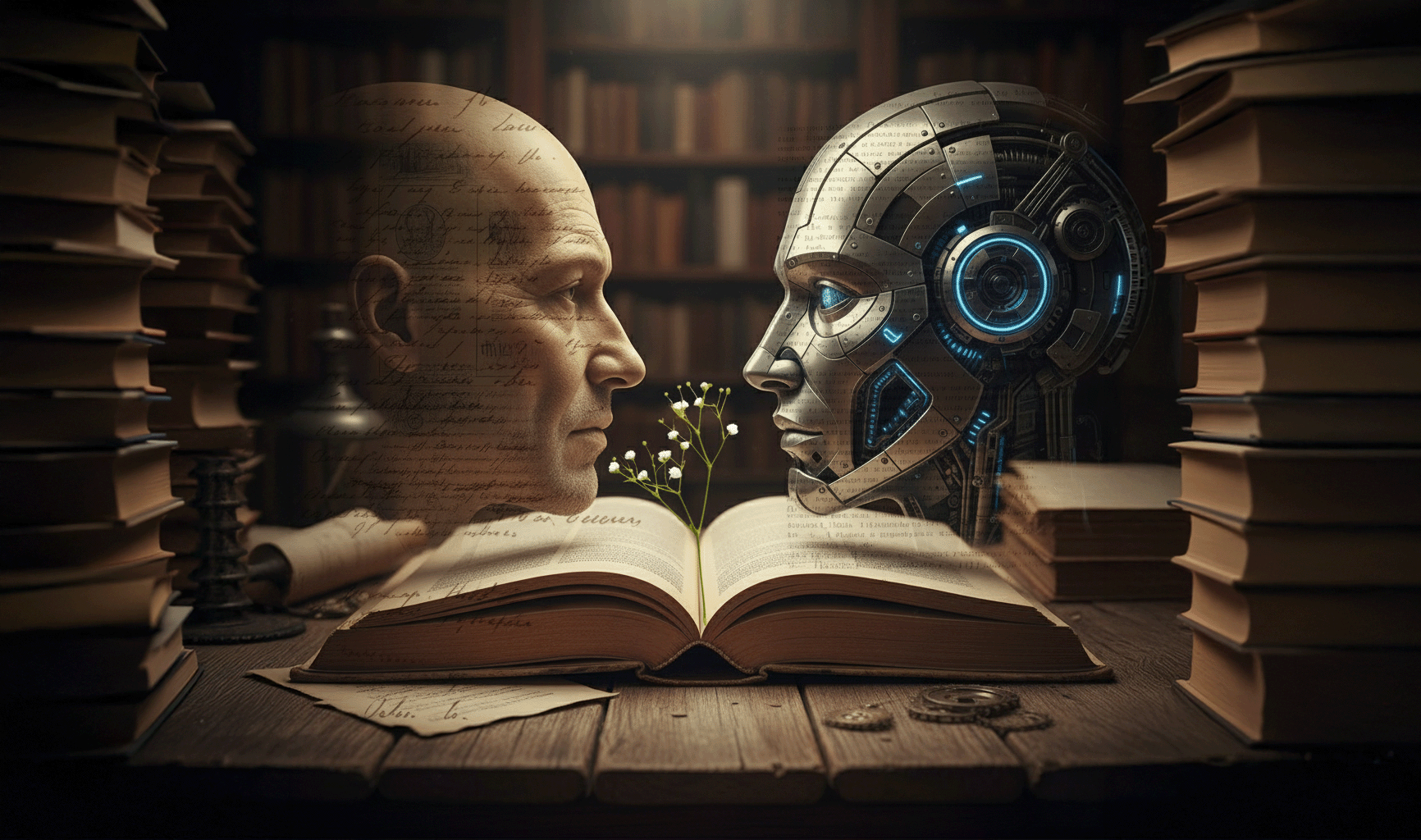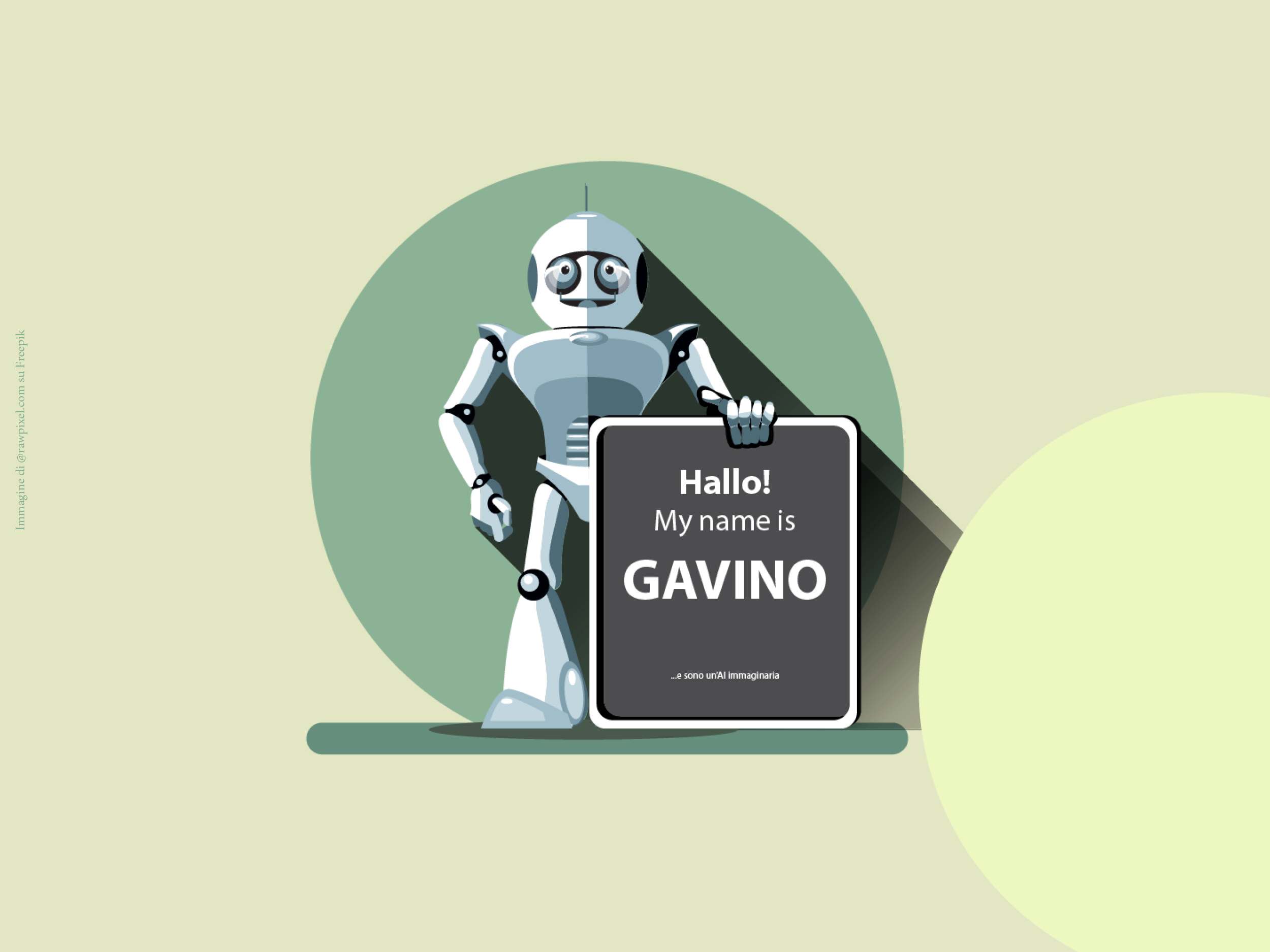Nell’immaginario dominante, l’innovazione nasce nei centri: nelle metropoli, nei campus, nei distretti tecnologici. I territori periferici vengono descritti come ritardatari, destinatari di politiche compensative, luoghi da “connettere” o da “riattivare”. Ma è proprio ai margini che oggi si stanno formando i laboratori più radicali di ricerca: luoghi dove la scarsità diventa metodo, dove il tempo si allunga e la complessità non si traduce in semplificazione.
Un territorio periferico non è un’assenza: è un diverso regime di conoscenza. Qui la ricerca non è solo accademica, ma quotidiana, comunitaria, ambientale. Ogni decisione, su energia, acqua, suolo, cibo, è una forma di sperimentazione collettiva, un equilibrio fragile tra tecnica e sopravvivenza. È questa prossimità al limite che rende i territori marginali luoghi epistemici, non decorativi.
In molte aree alpine, appenniniche, insulari, si stanno sviluppando esperienze che anticipano il futuro: cooperative energetiche che gestiscono dati e sensori, scuole di montagna che integrano intelligenza artificiale e saperi artigiani, imprese agricole che usano la tecnologia per preservare la biodiversità invece di distruggerla. Non sono “casi” locali, ma esperimenti di una nuova ecologia della conoscenza, in cui la tecnologia è chiamata a stare nel mondo, non a sostituirlo.
Ripensare le politiche territoriali in questa prospettiva significa non esportare modelli, ma costruire condizioni di ricerca diffuse. Significa riconoscere che la conoscenza non è un flusso da centri a periferie, ma un campo che si rigenera localmente. Ogni territorio dovrebbe poter disporre di infrastrutture cognitive proprie: università distribuite che si intrecciano con le economie reali, laboratori civici che trasformano dati e pratiche quotidiane in strumenti di decisione, intelligenze territoriali capaci di apprendere dal contesto anziché estrarlo.
Non si tratta solo di decentramento amministrativo, ma di ridistribuzione epistemica: spostare la ricerca dal possesso di risorse alla capacità di interpretarle; dal consumo di conoscenza al suo radicamento. Un’innovazione che nasce dal territorio non è più un prodotto da scalare, ma un metodo da condividere.
L’iperlocale non è chiusura: è l’opposto, è la soglia attraverso cui il mondo torna a farsi concreto perché ogni territorio che sperimenta, insegna e ogni periferia che resiste, produce conoscenza.