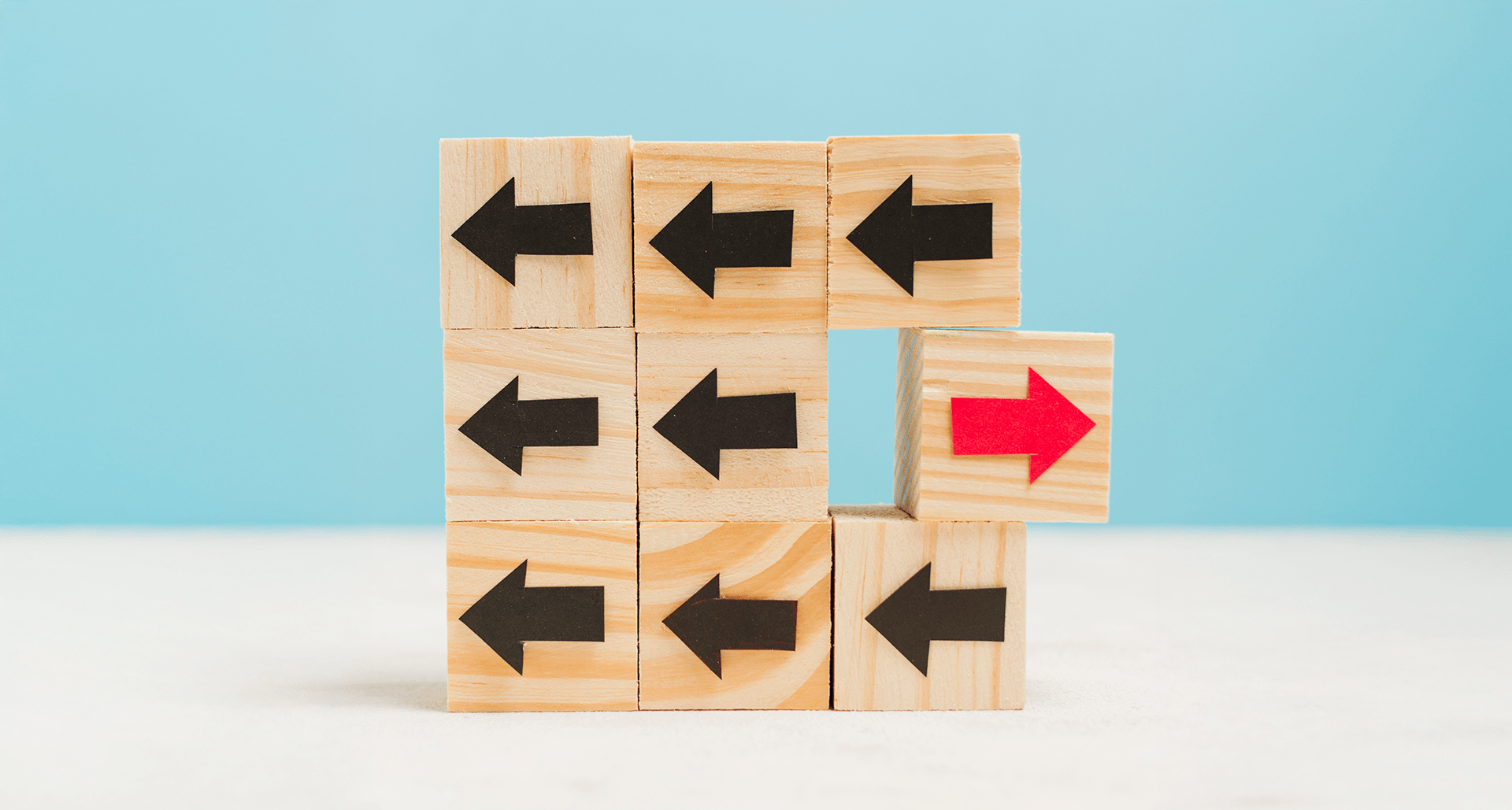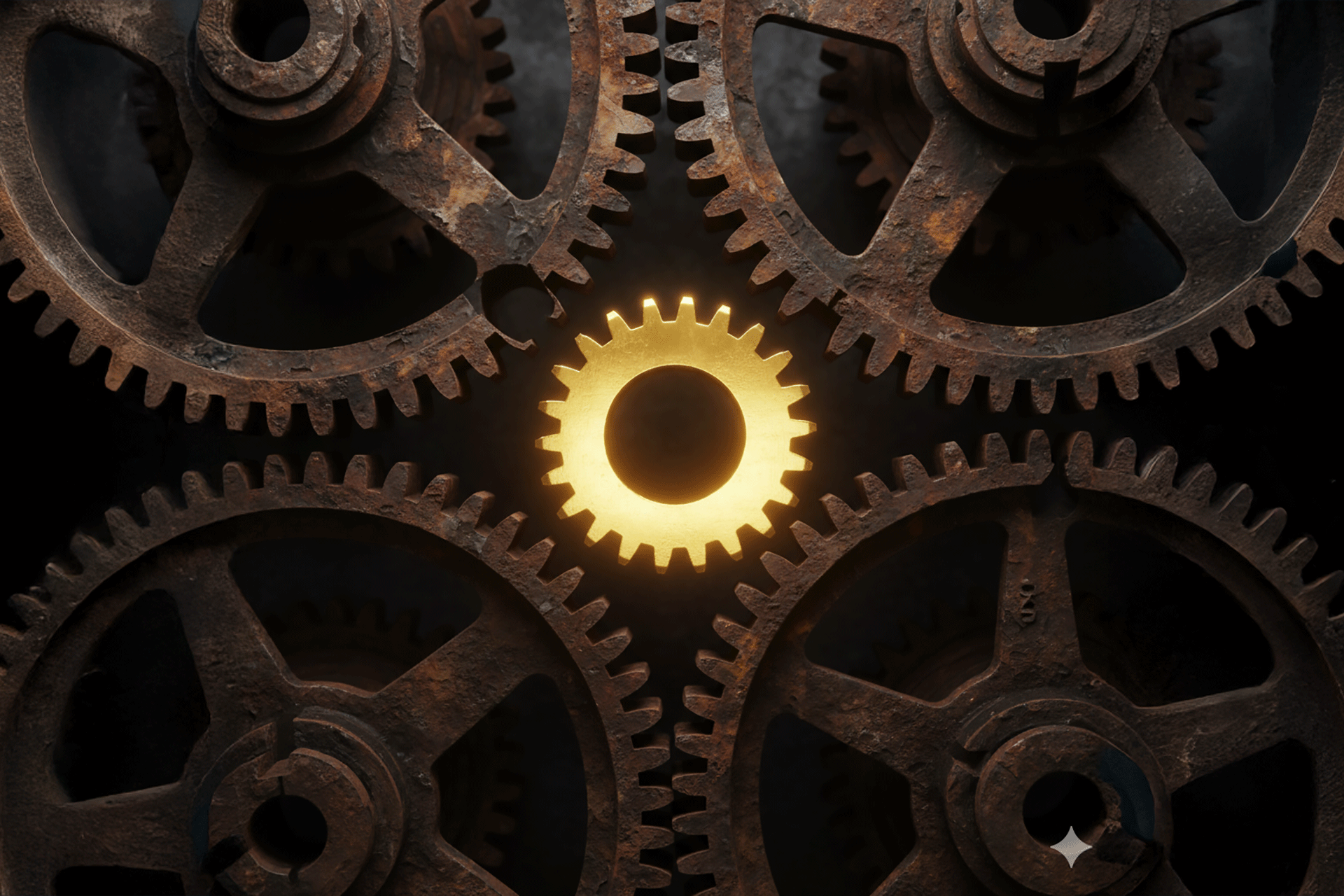I territori che soffrono oggi sono il nostro specchio, riflettono l’incapacità di politiche a ogni livello di invertire tendenze che sembrano inevitabili, spopolamento, invecchiamento, mancanza di lavoro e il progressivo venir meno di servizi essenziali.
Queste aree, però, rappresentano il nostro bene rifugio più prezioso, non solo in termini materiali, ma anche culturali e identitari. Tuttavia, vengono trattate come scarti di una modernità in cui le logiche economiche prevalgono su quelle sociali e il margine è destinato a restare tale, inghiottito da un circolo vizioso che lo priva di opportunità.
Non è più tollerabile accettare questa forma di marginalizzazione, che non è solo economica, ma anche culturale e sociale. Ridurre un territorio alla sua mera capacità di generare profitto significa tradire i principi su cui si fonda uno stato sociale. Il diritto a una vita dignitosa per tutti, indipendentemente dal luogo di nascita o residenza.
I servizi essenziali, dalla sanità ai trasporti, dall’ambiente all’istruzione, non possono essere soggetti a un mero conto economico. Devono essere considerati investimenti strutturali, con tassi di rendimento che non si misurano in termini di PIL, ma in coesione sociale, benessere e qualità della vita.
Ma chi vive o vorrebbe vivere in questi territori?
Conosciamo davvero le aspettative, i sogni e le necessità dei giovani che li abitano?
E, soprattutto, di quelli che li lasciano?
Non basta ascoltare la voce dei pochi che, spesso con sacrifici personali e familiari, riescono a frequentare università o a trovare lavoro altrove.
È necessario un approccio inclusivo, che dia spazio anche a chi resta, a chi vorrebbe partire ma non può, e a chi desidera rientrare ma non trova le condizioni per farlo.
Per molti giovani, la partenza non è una scelta, ma una necessità.
E per chi parte, le opportunità di ritorno sono spesso poco più che promesse vuote, tradite da politiche pubbliche inadeguate.
Si può ricucire questa frattura?
Si può rendere di nuovo attrattivo ciò che oggi è considerato periferico?
La risposta è sì, ma solo se comprendiamo che le distanze, fisiche e sociali, sono relative. Laddove si investe in infrastrutture moderne, connettività digitale e trasporti efficienti, le aree marginali possono trasformarsi in hub di innovazione e comunità resilienti.
Questo richiede però un cambio radicale di prospettiva.
Non possiamo limitare il nostro intervento a misure emergenziali o a incentivi temporanei.
Servono visioni di lungo periodo, che riconoscano il valore intrinseco dei territori e delle persone che li abitano.
Chi sono i giovani interessati a restare o a tornare in queste aree?
Non sono necessariamente coloro che cercano un ritorno alle tradizioni, ma quelli che vedono nel territorio un’opportunità per costruire qualcosa di nuovo, un equilibrio tra qualità della vita, innovazione e radicamento culturale.
Questi giovani non vogliono essere relegati ai margini, ma chiedono opportunità reali. Formazione di alto livello, accesso al lavoro qualificato, spazi per creare imprese, e una comunità che li sostenga.
Le loro motivazioni non sono solo economiche, ma spesso legate al desiderio di appartenenza, di contribuire a una rinascita collettiva che superi il senso di abbandono.
Le politiche pubbliche possono fare molto per favorire questa inversione di tendenza.
Creare incentivi per il ritorno, promuovere l’accesso a fondi per l’imprenditoria giovanile, e garantire una connessione reale tra centri urbani e aree periferiche sono solo alcuni esempi.
Ma tutto questo sarà vano senza un cambio di narrativa.
I territori marginalizzati non devono essere più visti come luoghi da cui fuggire, ma come spazi di opportunità.
Questo richiede investimenti materiali, ma anche culturali.
Bisogna ricostruire il senso di comunità, valorizzare i legami sociali e riscoprire il potenziale che queste aree racchiudono.
Ricucire i territori significa ricostruire una parte essenziale della nostra identità collettiva. Significa smettere di trattare i giovani come un capitale da esportare e iniziare a vederli come custodi del futuro delle nostre comunità.
Per ottenere risultati concreti e duraturi, è necessario adottare un mix articolato di politiche capaci di affrontare le molteplici sfide di questi territori. Servono strumenti che combinino sostegno all’avvio di imprese con forme di credito agevolato per i giovani e per chi desidera intraprendere attività produttive innovative. È fondamentale garantire accesso alle terre pubbliche, rurali o comunali, magari a uso gratuito o a costi simbolici, per incentivare l’agricoltura, l’artigianato e altre iniziative legate all’economia locale. Un altro tassello cruciale è il supporto alla genitorialità e alla famiglia, con politiche di conciliazione vita-lavoro che comprendano asili nido accessibili, sostegno alla cura degli anziani e flessibilità lavorativa. Queste misure, integrate da infrastrutture efficienti – come connettività digitale ad alta velocità e trasporti accessibili – possono trasformare le aree marginali in poli attrattivi, anziché in luoghi di abbandono.
Sembrano banalità. Ma perché non sono attuate?
Solo così potremo trasformare le aree marginalizzate in luoghi di innovazione e speranza, restituendo dignità a chi le abita e creando un nuovo equilibrio tra centro e periferia, tra passato e futuro.
Pensando alla mia amata Sardegna, Nicola