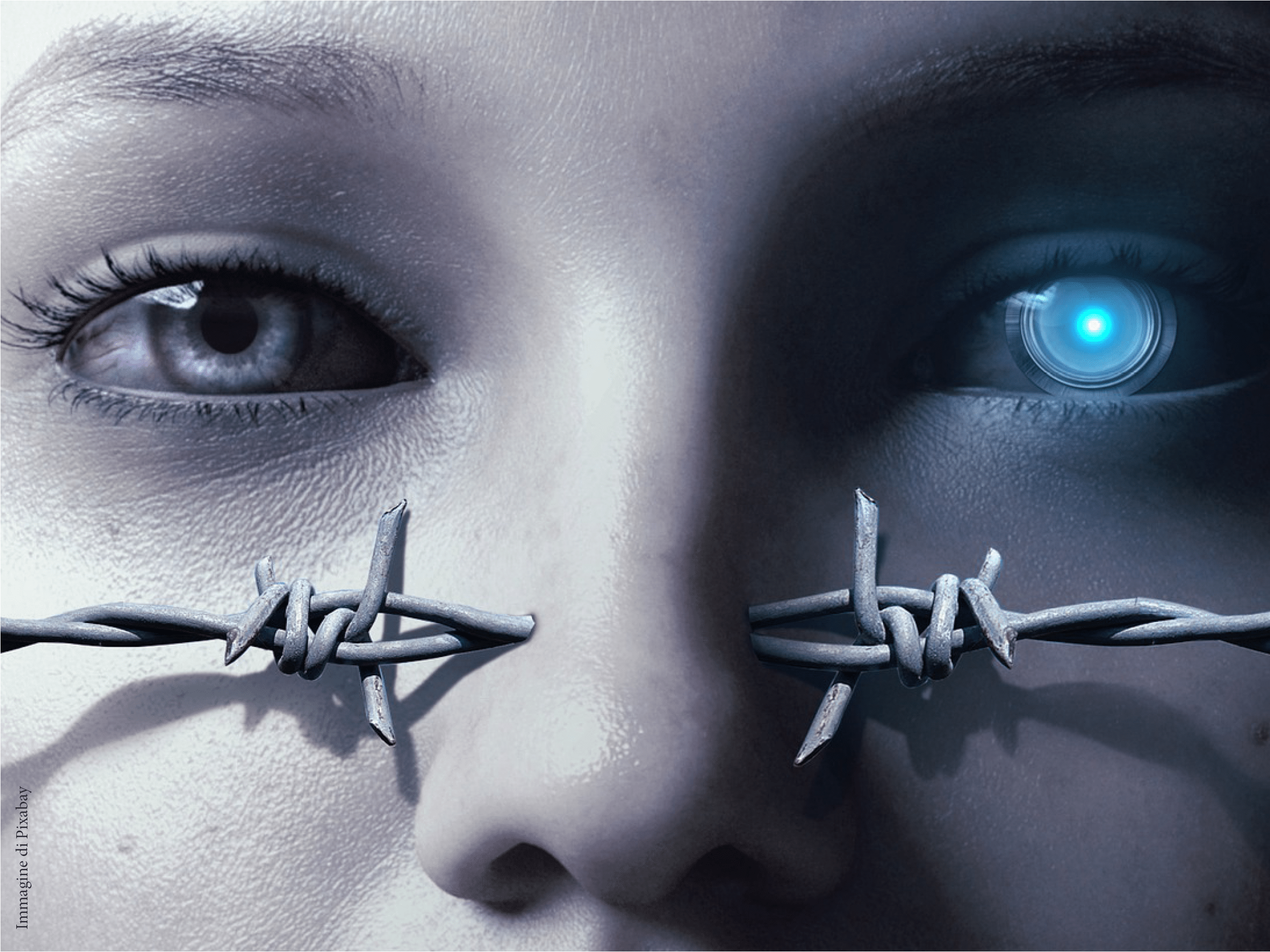Nel mondo ci sono tanti modi di interpretare l’industria dell’innovazione, così come ci sono molti differenti ecosistemi a sostegno della stessa.
Certamente quello italiano è un caso a sé stante, come quello californiano è differente da quello israeliano. E così via gli altri.
Se negli States c’è un mercato guidato dai grandi fondi d’investimento privati, nella sponda ovest del Mediterraneo c’è forse una grande spinta alla ricerca che proviene dall’esercito.
Ma anche lì non mancano i fondi. Alcuni sistemi ne scimmiottano altri, qualcuno cerca una via propria. Tutti hanno difficoltà. Tutti sembra che siano arrivati ad un bivio per la propria seconda vita.
Nel Belpaese certamente abbondano creatività, inventiva, capacità raffinata di ricerca ed un modo tutto nostro di creare impresa e portarla nel mercato.
Ora, a prescindere dalla corretta definizione di startup, quel che è certo dopo questa sbornia decennale condita con tanta fuffa, c’è bisogno nei nostri territori di nuove aziende, meglio se innovative, ma, a prescindere dal fatto che siano startup in senso proprio, a condizione che immettano nel mercato un prodotto o un processo con ricadute concrete nell’economia reale e nella vita delle persone. Basta stupidaggini che durano il tempo di uno starnuto.
Sarebbe opportuno che rientrassero a pieno titolo nelle agende di governo nazionali e regionali le politiche attive del lavoro propriamente dette e che si smettesse di mascherarle da azioni a sostegno dell’innovazione. In questi casi gli ibridi non funzionano.
E poi all’industria dell’innovazione servono strumenti dedicati e mirati. Oltre che soldi.
Se non si investe (dove investire ed assumersi il rischio sono due significati ancora da digerire per le parti politiche e per gli investitori) non si genera futuro né si risolvono i problemi che attanagliano molti dei territori della nostra bistrattata Penisola.
Per quali mercati pensiamo i nuovi prodotti e servizi?
Produciamo per la grande industria o perché abbiamo trovato un nuovo mercato?
Abbiamo chiaro il modello di business con cui vogliamo metterci in gioco?
L’abbiamo misurato con un solido piano industriale?
Abbiamo chiare le linee di comunicazione e marketing che ci serviranno per farci conoscere?
Sappiamo come impostare l’amministrazione, la finanza ed il controllo per evitare che ci crolli l’azienda sotto i piedi?
Abbiamo chiaro come relazionarci con le banche e/o con gli investitori professionali?
Abbiamo chiaro come proteggere la proprietà intellettuale sui cui abbiamo investito i nostri soldi ed il nostro lavoro prima di affrontare il mercato?
Come detto in altre circostanze, dismettiamo la resilienza a favore dell’antifragilità, smettiamo di pensare che quello che funziona nell’industria dell’innovazione tal quale possa essere declinato come politica pubblica o, addirittura, possa diventare modello per la trasformazione urbana dei grandi poli cittadini nazionali. A ciascuno il suo.
Cerchiamo di familiarizzare con le tecniche di costruzione degli scenari, impariamo a sviluppare capacità previsionali che abbiano alla base modelli di calcolo scientifici, ragioniamo ancora meglio sulle cause e sui significati dei cimiteri delle startup sparsi in tutto il mondo.
Se vogliamo fare impresa dobbiamo crederci, serve abnegazione, dobbiamo avere fiducia in noi stessi e nel futuro, negli altri, dobbiamo essere coesi e cercare le giuste alleanze, serve solidarietà tra persone, tra imprese, tra territori, tra enti e tra nazioni.
Altrimenti il futuro non ci farà sconti e continueremo col rosario di errori e lamentele con cui andiamo avanti da decenni senza che nulla muti mai.
Buon futuro a Tutt*, noi ci crediamo, ci lavoriamo senza sosta.
Un sorriso, Nicola